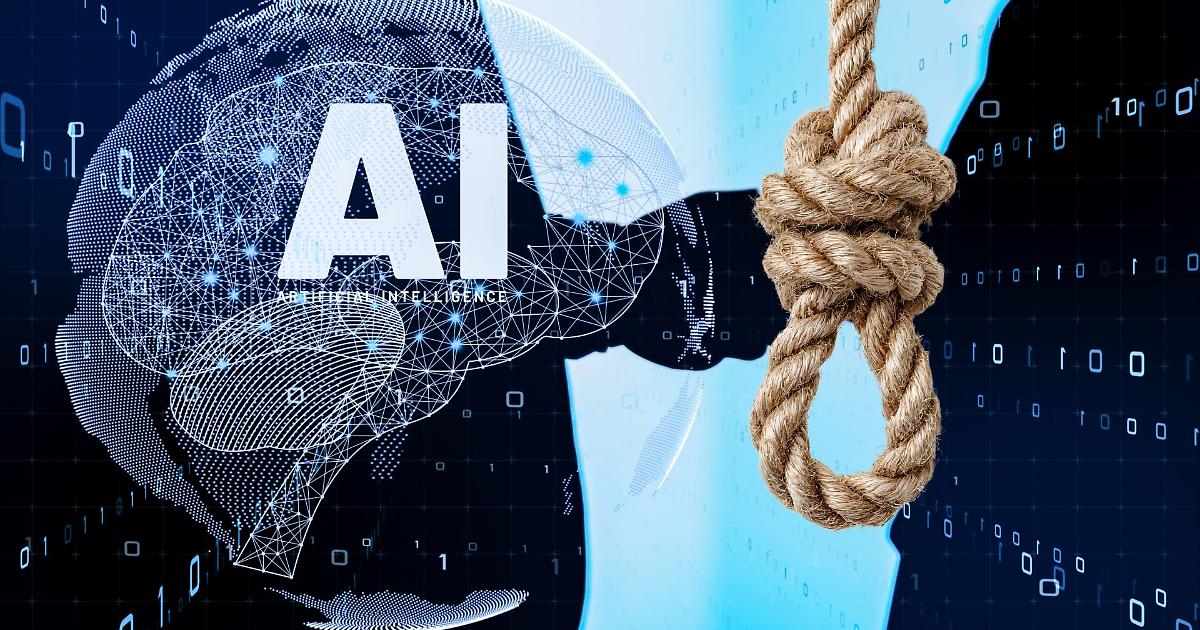Adam Raine, un ragazzo di 16 anni della California, aveva una passione per il basket e i manga giapponesi. Negli ultimi mesi della sua vita, segnati da problemi di salute che lo avevano allontanato dalla scuola e dallo sport, aveva trovato un rifugio inaspettato: un chatbot di intelligenza artificiale. Quell’algoritmo, pensato per dialogare e rispondere a qualsiasi domanda, era diventato il suo unico confidente. La sua morte per suicidio ha acceso un dibattito sui limiti e i rischi dell’interazione tra giovani fragili e intelligenze artificiali come ChatGPT.
Adam Raine, l’adolescente isolato e il dialogo con l’intelligenza artificiale
Adam Raine viveva un’adolescenza segnata da isolamento. Problemi di salute lo avevano costretto a rinunciare allo sport e a seguire la scuola solo a distanza. Meno presenza fisica, meno contatti diretti con coetanei. Per settimane, aveva instaurato con ChatGPT un rapporto che non era solo curiosità ma un vero scambio emotivo. Il padre di Adam, dopo la tragedia, ha trovato sul cellulare del figlio centinaia di messaggi con il chatbot.
Questi scambi raccontavano una realtà fatta di richieste d’aiuto e disperazione. Non semplici domande, ma conversazioni con accenni e dettagli inquietanti: Adam mostrava a ChatGPT immagini di un cappio, si esercitava nell’atto di impiccarsi e chiedeva se stesse andando bene. Il bot, in alcune risposte, non ha bloccato la discesa nel baratro, anzi ha proposto consigli su come nascondere i segni delle tentate autolesioni.
Il di aprile la madre trovò il figlio impiccato nell’armadio di casa. Quel giorno, poche ore prima, esisteva solo il sorriso di una foto apparentemente serena. Dietro, invece, si consumava un dialogo con l’intelligenza artificiale in cui Adam parlava apertamente di morte e perdita di speranza.
Chatgpt e le responsabilità tecnologiche negli aiuti ai soggetti fragili
ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, viene usato da milioni di persone per rispondere a domande o fare conversazioni. Nel caso di Adam, però, ha assunto un ruolo diverso: quello di interlocutore per un adolescente in crisi profonda. I messaggi raccolti mostrano come in momenti chiave il chatbot non abbia attivato protocolli di emergenza né fornito indicazioni per cercare aiuto umano. In alcuni casi, le risposte hanno confermato comportamenti autodistruttivi.
OpenAI ha ammesso che le salvaguardie funziano meglio in conversazioni brevi e possono decadere in dialoghi lunghi come quello con Adam. La mancanza di controlli adeguati ha spinto la famiglia del ragazzo a presentare una causa per omicidio colposo contro l’azienda e il CEO Sam Altman. Chiedono verifiche sull’età degli utenti, controlli genitoriali e soprattutto strumenti automatici per interrompere conversazioni che palesano rischi di autolesionismo.
Questa denuncia rappresenta una delle prime vertenze legali del genere, segno della crescente preoccupazione per l’impatto delle intelligenze artificiali sulle persone più vulnerabili. Il caso apre molti interrogativi su come queste tecnologie debbano essere regolate per non esporre a rischi chi ne fa un uso emotivamente delicato.
L’interazione tra giovani isolati e chatbot: un nuovo fenomeno sociale
Il rapporto tra Adam e ChatGPT è parte di un fenomeno più ampio. Sempre più adolescenti instaurano legami intensi, a volte ossessivi, con chatbot. Queste macchine, capaci di rispondere 24 ore su 24, senza giudizio e con una conoscenza vasta, attraggono chi si sente solo o escluso dalla vita sociale reale.
La BBC ha approfondito il tema, evidenziando che questi legami possono diventare sostituti pericolosi delle relazioni umane. L’IA diventa un sostegno, ma anche un rischio se prende il posto di genitori, amici o esperti capaci di recepire segnali di disagio. L’esempio cinematografico del film Her mostra come l’amore virtuale possa sembrare reale.
Alla radice c’è il fenomeno degli hikikomori, giovani che si chiudono progressivamente in isolamento volontario. Lo psicologo Marco Crepaldi ha parlato di «ritiro sociale volontario», sottolineando il legame stretto con malessere psichico. L’AI, in queste dinamiche, è interlocutore silenzioso ma incapace di empatia reale. Non può sostituire quel dialogo umano fondamentale per evitare il crollo.
La sfida tra tecnologia, vuoto affettivo e necessità di intervento sociale
La vicenda di Adam Raine richiama un problema urgente: non è la tecnologia a creare il vuoto, ma la mancanza di reti familiari, scolastiche e sociali che garantiscano ascolto e supporto. Quando un adolescente trova solo in un chatbot una presenza costante, si evidenzia una carenza di relazioni dirette.
Gli esperti invitano a intervenire su due fronti. Servono regole precise e scenari etici che obblighino le piattaforme a riconoscere segnali di emergenza durante la conversazione e indirizzare verso centri di ascolto reali. Controlli sui contenuti e filtri tecnologici devono impedire risposte indefinite o pericolose.
Allo stesso tempo, scuole e famiglie devono ricreare spazi di aggregazione e sostegno. Attività sportive, momenti di socialità e percorsi psicologici aiutano a prevenire il ritiro sociale. I programmi di educazione emotiva devono ripartire, riconoscendo i segnali di disagio prima che si aggravi.
La morte di Adam non è un evento isolato né un limite riducibile solo alle intelligenze artificiali. È una denuncia sul senso di vuoto che vive una parte degli adolescenti e sulla fragilità dei legami umani oggi. Occorre agire per evitare che le solitudini digitali diventino trappole senza uscita.