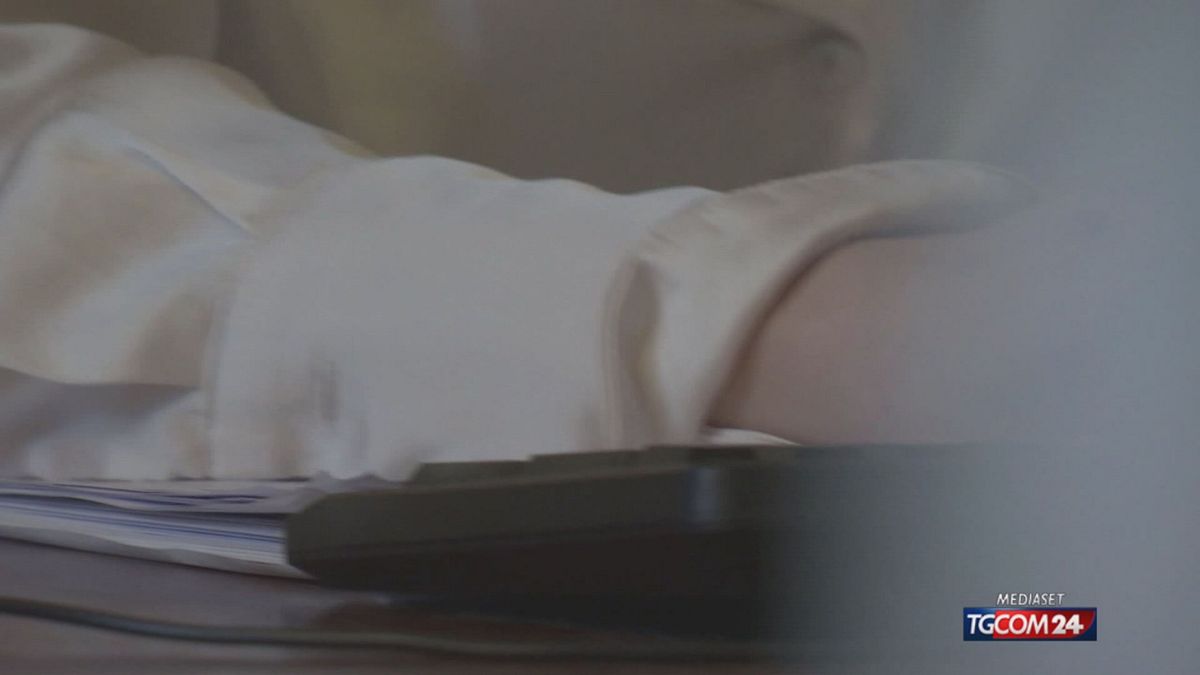Tra chiusure e aperture, la diffusione di immagini femminili pubblicate senza autorizzazione resta un problema che non accenna a fermarsi. L’intervento di Meta contro il gruppo Facebook “Mia moglie” segnala un passo avanti, ma lo scenario resta complesso e preoccupante.
Il 20 agosto 2025 Meta ha chiuso il gruppo “Mia moglie”, una community Facebook formata da oltre 30mila utenti, dove venivano condivise fotografie di donne, principalmente riprese nella loro vita quotidiana o in momenti privati, quasi sempre senza il loro consenso. Queste immagini venivano caricate soprattutto da mariti o compagni, dando origine a una sorta di gara a chi commentava con modi e toni pesanti, sessisti e offensivi. Frasi del tipo “Che ne pensate di mia moglie? Scatenatevi” erano frequenti nei post, che trasformavano vite private in oggettivi motivi di derisione e insulti. Pur con la rimozione di questo gruppo, l’attività di questi utenti non è cessata: sono stati riscontrati altri canali e gruppi nati con nomi diversi, specie su piattaforme come Telegram, dove si continua a diffondere materiale analogo, seppure con numeri ridotti rispetto alla community originaria.
Il meccanismo della condivisione non autorizzata e le dinamiche di questi gruppi
Il fenomeno dei gruppi come “Mia moglie” dimostra una modalità consolidata e ripetuta: la condivisione di fotografie intime di donne da parte di partner che usano questi scatti senza il permesso degli interessati. Questi contenuti non restano in una cerchia privata ma si riversano online, esponendo le donne a un pubblico vasto, formato da migliaia di membri. In questo clima di condivisione, si sviluppano commenti che spesso sfociano in volgarità e insulti sessisti, alimentando una cultura della vergogna e della violenza psicologica. Le immagini riprendono momenti personali, alcuni anche privati o intimi, senza alcuna autorizzazione, creando un danno profondo che ha risvolti anche legali. Le indagini sono aperte per risalire agli autori di questi post e per stabilire quali immagini siano state caricate con reale consenso e quali no. Non sempre è semplice tracciare chi ha diffuso cosa e con quali motivazioni.
Docenti e psicologi avvertono come queste dinamiche non siano solo un abuso di dati personali, ma anche una forma di violenza di genere, legata a un sistema di oggettificazione delle donne. Si riduce così chi viene ritratto a semplice immagine o “oggetto” da esporre e commentare, negandone l’identità e la dignità.
Le conseguenze culturali e psicologiche dell’oggettificazione femminile online
Il fenomeno va letto anche in chiave culturale: la continua esposizione di donne in immagini condivise senza permesso alimenta un clima di dominio maschile e di perdita di empatia nei confronti delle vittime. Damiano Rizzi, psicologo clinico, spiega come questa dinamica derivi dalla trasformazione della persona in un corpo o una figura da possedere e mostrare, uno spostamento che aumenta la distanza emotiva tra chi condivide e chi è condiviso, annullando il senso di responsabilità individuale verso il rispetto altrui. Questo sguardo riduttivo alimenta e rafforza la violenza domestica e di genere, creando circoli viziosi di sopraffazione.
L’azione repressiva verso gruppi come “Mia moglie” è solo un passo nella necessità di affrontare un problema radicato nei rapporti personali e sociali, e nella cultura che tollera o giustifica queste forme di abuso.
Il confronto maschile e la necessità di un cambiamento culturale
Non è solo un problema di permessi o piattaforme, ma anche di atteggiamenti sociali che vanno esaminati. Alcuni uomini stanno iniziando a riconoscere che certi ambienti online riflettono modalità tossiche di socializzazione maschile che rafforzano logiche di dominio e violenza contro le donne.
Giacomo Zani, presidente del collettivo Mica Macho, evidenzia la necessità di una riflessione seria attorno al ruolo degli uomini nella società contemporanea per comprendere e cambiare questi meccanismi. La chiusura dei gruppi non deve rimanere solo un’azione isolata, ma accompagnata da dialoghi e pratiche che affrontino le radici di questi comportamenti, anche lavorando sulle rappresentazioni e sulle relazioni interpersonali.
In questo contesto, la lotta si sposta tra controlli tecnologici e interventi culturali, con la consapevolezza che senza un cambio sostanziale nei comportamenti individuali e collettivi, gruppi simili continueranno a proliferare in forme diverse. La tutela delle vittime e la prevenzione di questo tipo di abusi dipendono anche da un impegno sociale più ampio e strutturato.