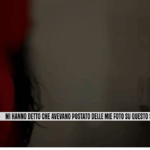L’eruzione dell’Ignimbrite Campana, avvenuta circa 39 mila anni fa, ha profondamente influenzato la geologia e la morfologia della Campania. Questo evento vulcanico ha prodotto depositi piroclastici di notevole spessore, alterando la conformazione del terreno e l’ambiente circostante. Nei secoli successivi, l’estrazione del tufo, materiale derivato da questa eruzione, ha trasformato ulteriormente il territorio, in particolare nell’area dei Campi Flegrei. Nel testo che segue si approfondisce la storia geologica e le trasformazioni territoriali legate a questa eruzione, tra le più significative del Quaternario europeo.
L’eruzione dell’Ignimbrite Campana e la formazione dei depositi piroclastici
Circa 39 mila anni fa, l’Ignimbrite Campana ha rappresentato uno degli eventi vulcanici più imponenti del Quaternario europeo. L’eruzione ha generato un flusso piroclastico composto da ceneri e materiali incandescenti che si sono diffusi rapidamente e a temperature elevate. Il deposito risultante ha raggiunto spessori di decine di metri, modificando profondamente la morfologia della Piana Campana e delle aree limitrofe.
Il termine “Tufo Grigio Campano” indica questi sedimenti emessi durante l’eruzione. Questi depositi hanno coperto vaste superfici, innalzando il terreno anche di 50 metri rispetto al livello precedente. Le comunità insediate successivamente hanno dovuto adattarsi a una topografia completamente trasformata.
Studi recenti condotti dall’INGV e da altri enti di ricerca evidenziano che questa eruzione ha avuto ripercussioni anche sul clima regionale, provocando variazioni temporanee dell’ambiente. L’evento è molto più esteso e potente rispetto all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano.
La struttura calderica dei Campi Flegrei e la sovrapposizione delle eruzioni
I Campi Flegrei sono una vasta caldera vulcanica situata nella parte centrale della Piana Campana. La loro configurazione attuale deriva da due grandi collassi calderici avvenuti nell’arco di decine di migliaia di anni. Il primo collasso è associato all’eruzione dell’Ignimbrite Campana, che ha formato la caldera più estesa.
In seguito, nel settore sud-occidentale di questa caldera, si è sviluppata una caldera secondaria legata all’eruzione del Tufo Giallo Napoletano. Questa sovrapposizione spiega la complessità geologica e vulcanica dell’area, che conta oltre settanta centri eruttivi attivi negli ultimi 39 mila anni.
La caldera è soggetta a fenomeni di bradisismo, con cicli di innalzamento e abbassamento del suolo, che rappresentano indicatori fondamentali per il monitoraggio dell’attività vulcanica. Negli ultimi anni sono stati implementati sistemi avanzati di sorveglianza sismica e deformativa, vista la presenza di popolazioni nelle zone circostanti.
Le modificazioni morfologiche legate all’estrazione e all’uso del tufo
Dal passato fino alla metà del Novecento, la Campania ha visto un’intensa attività estrattiva di tufo, materiale vulcanico facilmente lavorabile e utilizzato nell’edilizia. Le cave a fossa, o a cielo aperto, si sono diffuse in pianura, insieme a cavità sotterranee e pozzi, creati per prelevare blocchi di tufo a profondità contenute.
Questa attività ha lasciato un’impronta evidente sul paesaggio campano, con ampie aree trasformate in cave e modifiche significative sia in superficie sia nel sottosuolo. Le cave a fossa hanno generato grandi depressioni, modellando un territorio che si basa in gran parte sui depositi dell’Ignimbrite Campana.
Oltre all’aspetto economico, l’estrazione ha avuto un impatto ambientale rilevante: oggi la gestione delle cave è regolata per prevenire rischi come smottamenti o cedimenti e per favorire il recupero ambientale. I materiali tufacei, legati alla storia vulcanica dell’area, rappresentano un patrimonio geologico importante, strettamente connesso all’evoluzione naturale e umana della regione.
La trasformazione del territorio campano, avviata da eventi millenari come l’eruzione dell’Ignimbrite Campana e poi modificata dall’attività umana, racconta la storia di un’area in cui natura e uomo si sono intrecciati, offrendo una chiave per comprendere il paesaggio attuale.