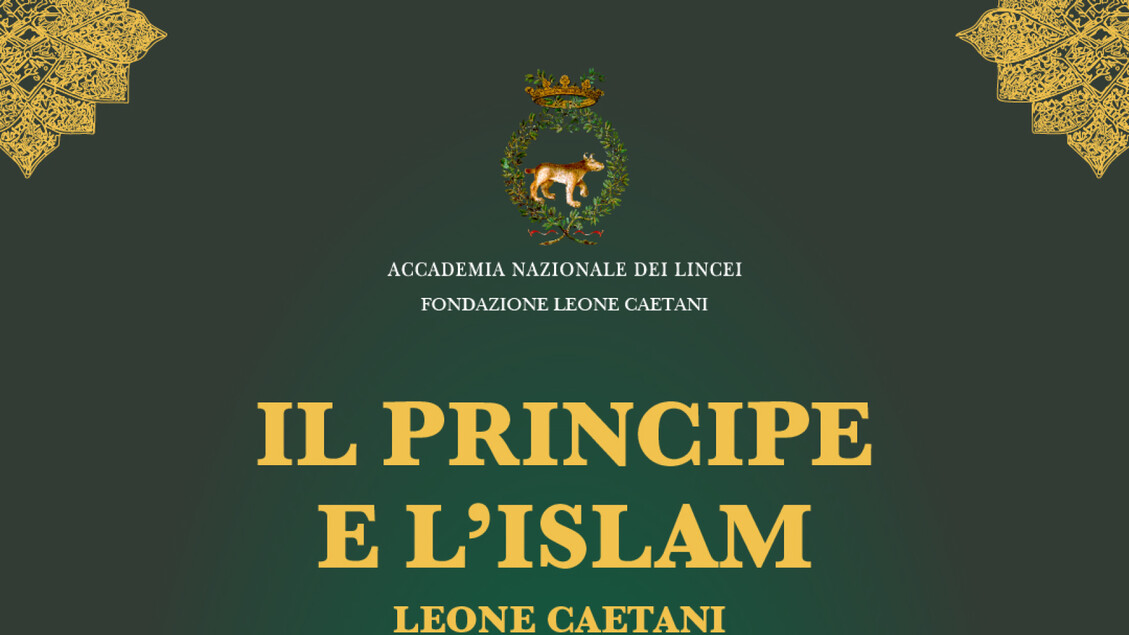Leone Caetani di Sermoneta ha lasciato un segno profondo nello studio delle culture orientali e nell’impegno politico italiano di inizio Novecento. La sua figura si intreccia a doppio filo con la ricerca scientifica sull’islam e con la vita accademica nazionale, in particolare tramite i suoi legami con l’Accademia nazionale dei Lincei. A 156 anni dalla nascita, la sua storia torna a vivere attraverso una mostra che ripercorre il percorso intellettuale e personale di un nobiluomo fuori dagli schemi, che ha attraversato momenti cruciali della storia europea e asiatica.
la formazione e gli interessi culturali di leone caetani
Nato a Roma nel 1869, Leone Caetani si distingueva già negli anni universitari per la sua forte passione verso le lingue orientali e le culture islamiche. Appartenente a una delle famiglie nobiliari più in vista della capitale, Caetani avrebbe potuto limitarsi all’aspetto politico o mondano. Invece, si dedicò con estrema attenzione allo studio del Corano, dell’ebraico, del persiano e di altre lingue antiche, come l’assiro e il sanscrito. Questa scelta, piuttosto rara per un aristocratico dell’epoca, segnò la sua esistenza intera e la sua attività futura. Iniziò a costruire così una cultura solida che lo portò ad essere considerato tra i primi in Europa a leggere le origini dell’islam partendo solo dalle fonti arabo-islamiche, con un metodo rigoroso e lontano da pregiudizi o approcci superficiali.
Il suo impegno intellettuale si sviluppò parallelamente a una carriera politica, durante la quale mantenne sempre una distanza critica rispetto alle idee dominanti, in particolare sul colonialismo italiano. La sua conoscenza approfondita gli permise di individuare fin da subito le contraddizioni e le falsità della propaganda governativa, soprattutto riguardo alla guerra di Libia. La sua attività all’interno del parlamento italiano fu per certi versi controversa, soprattutto dopo il celebre discorso del 7 giugno 1911, in cui denunciò pubblicamente “l’imbroglio di Tripoli” e cercò di scongiurare lo scoppio del conflitto.
il rapporto con l’accademia dei lincei e la fondazione culturale
Leone Caetani non si limitò a essere un semplice studioso, ma contribuì attivamente alla diffusione della cultura orientale in Italia, soprattutto grazie al legame stretto con l’Accademia nazionale dei Lincei. Pur non appartenendo formalmente a istituzioni accademiche, fu riconosciuto come socio stimato per il rigore della sua opera. Il valore del suo approccio scientifico trovò casa in una fondazione che prese il suo nome e si occupò di conservare e ampliare la raccolta di manoscritti orientali raccolti dal principe.
La mostra “Il principe e l’Islam. Leone Caetani e l’Accademia dei Lincei”, inaugurata l’8 maggio a palazzo Corsini, mette in luce proprio questo aspetto, presentando tre sezioni distinte. La prima è dedicata alla vita personale di Caetani e al suo ruolo pubblico, con fotografie, documenti e cimeli che ne tracciano il contesto storico e culturale. La seconda illustra le origini e lo sviluppo della fondazione nata per sostenere le ricerche da lui avviate. L’ultima parte raccoglie preziosi manoscritti miniati e testi originali in lingua araba e altre lingue orientali, materiale che la collezione dei Lincei custodisce e valorizza da decenni.
Impegno politico e conseguenze personali
La posizione assunta da Caetani contro la guerra libica gli costò molto a livello personale e politico. Il suo discorso parlamentare provocò forti reazioni, sia da parte della propaganda nazionalista sia tra i suoi stessi colleghi. Dopo aver perso il seggio, fu attaccato duramente con tentativi di delegittimazione della sua immagine pubblica, considerato un traditore della patria o un nemico del popolo. A 36 anni scelse allora di arruolarsi volontario nella prima guerra mondiale, una scelta dettata anche dalla volontà di riscattare il proprio onore e riacquistare credibilità.
Il ritorno dalla guerra non portò però la tranquillità sperata: una crisi personale lo spinse a lasciare l’Italia. Si trasferì in Canada, dove iniziò a costruire una nuova famiglia lontano dal clima di pressione e conflitto che aveva incontrato. Le sue posizioni socialiste, radicali e anticlericali erano in netto contrasto con il regime fascista, che sfruttò la sua cittadinanza canadese per togliere la cittadinanza italiana a Caetani nel 1935. Quell’anno, in Canada, Leone Caetani morì a Vancouver, privato anche dall’Accademia dei Lincei del suo status di socio.
il riconoscimento postumo e la mostra a palazzo corsini
Solo di recente, il nome di Caetani è stato riabilitato dall’Accademia dei Lincei. Nel marzo del 2025, a quasi novant’anni dalla sua morte, il principe di Teano è stato reintegrato alla classe accademica con un voto unanime, riconoscimento del valore e dell’onestà intellettuale della sua opera. Questo gesto segna una rivalutazione ufficiale che affianca alla sua figura quella di uno studioso rigoroso e di un uomo che, senza mezzi termini, non cedette mai alle pressioni politiche o ideologiche.
La mostra aperta fino al 29 giugno a palazzo Corsini, che si può visitare liberamente, permette di cogliere tutte queste sfaccettature. I visitatori possono immergersi nella storia di un personaggio che ha attraversato momenti chiave della cultura e della politica italiana, ma anche apprezzare la ricchezza dei testi e degli oggetti raccolti in una vita votata alla conoscenza. Una testimonianza concreta della complessità e della profondità di Leone Caetani, che ancora oggi ispira riflessioni sul rapporto tra cultura e potere nei primi decenni del Novecento.