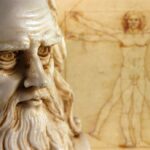Il progetto per la costruzione di una diga sul fiume Melito in Calabria, destinata a fornire acqua a mezzo milione di abitanti e a diverse aziende agricole, è stato definitivamente abbandonato. Un finanziamento di circa 260 milioni di euro, concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, è stato revocato dopo che oltre 102 milioni sono stati spesi senza portare a termine l’opera. Gare d’appalto, contestazioni su progetti e problemi di sicurezza hanno segnato l’iter di un’infrastruttura mai completata, causando anche danni ambientali nei luoghi interessati.
Lo sbarramento sul fiume melito e le perdite economiche in calabria
La diga, prevista tra i comuni di Gimigliano, Sorbo San Basile e Fossato Serralta in provincia di Catanzaro, rappresentava un’opera pubblica di grande rilievo per la regione. L’obiettivo era risolvere la carenza idrica che ogni anno mette a rischio l’agricoltura locale e le utenze civili di circa 500.000 persone. Il progetto, finanziato con fondi statali e nazionali, ha subito una brusca interruzione quando la Cassa per il Mezzogiorno ha revocato il finanziamento, giudicando il cantiere irrecuperabile.
Il Consorzio di bonifica ionio-catanzarese, responsabile della gestione e realizzazione dell’opera, ha speso circa 102 milioni di euro tra il 1998 e il 2015, senza riuscire a portare a termine i lavori. I manufatti eretti hanno causato un danno ambientale permanente, deturpando zone di pregio naturalistico e lasciando tracce di cemento armato inutilizzabili. Il doppio fallimento economico e ambientale è al centro di una contestazione formale da parte della Corte dei conti di Catanzaro. A rispondere in solido sono soprattutto gli ex dirigenti del consorzio, Pietro Filippa e Flavio Alfredo Talarico, che hanno seguito l’opera rispettivamente come responsabile unico del procedimento e direttore generale.
I problemi tecnici hanno bloccato il progetto della diga
Fin dai primi passi, il progetto ha incontrato evidenti criticità tecniche. Gli ispettori del ministero delle Infrastrutture, in particolare il Servizio Italiano Dighe, hanno sollevato dubbi sulla sicurezza dell’invaso e sulla robustezza delle strutture progettate. Il progetto originale, firmato da un tecnico poi deceduto, mostrava lacune tali da richiedere modifiche sostanziali per evitare rischi per le comunità a valle.
Le integrazioni richieste al progettista successivamente incaricato non hanno risolto i problemi. L’invaso continuava a presentare criticità tali da escludere la possibilità di completare l’opera senza mettere a rischio vite umane. Le autorizzazioni necessarie per proseguire i lavori erano mancanti o insufficienti. Nel frattempo, durante contenziosi con l’impresa appaltatrice, i costi del progetto sono letteralmente lievitati raggiungendo oltre 100 milioni spesi senza che la diga vedesse la luce.
La Corte dei conti evidenzia come la mancata adeguatezza del progetto e i ritardi abbiano di fatto compromesso il futuro della diga, rendendo inutilizzabile il denaro pubblico assegnato. La vicenda rappresenta uno degli esempi più gravi di spreco e inefficienza nel settore delle infrastrutture calabresi.
Impatti ambientali e conseguenze sul territorio calabrese
Il danno non riguarda solo le casse dello stato ma anche il territorio. I manufatti costruiti, non più funzionali, hanno alterato ecosistemi in aree di alto valore naturalistico. La presenza di tonnellate di cemento armato ha lasciato tracce visibili nel paesaggio e modificato il terreno, con conseguenze negative sulla flora e fauna locali.
L’impatto ambientale diventa ancor più rilevante se si considera il mancato beneficio che la diga avrebbe portato. Invece di risolvere i problemi di siccità che affliggono vaste zone della Calabria, l’opera si è trasformata in una ferita aperta. La diga avrebbe dovuto garantire oltre alla riserva idrica, anche la produzione di energia idroelettrica per circa 50 comuni a valle, contribuendo così all’autonomia energetica della regione.
Gli enti coinvolti e gli inquirenti continuano a valutare la portata dei danni e il possibile recupero delle aree interessate. La vicenda ha suscitato attenzione in ambito regionale e nazionale, richiamando la necessità di maggiore controllo nelle procedure di assegnazione e gestione dei progetti strategici.
Il ruolo della procura della corte dei conti nelle indagini sul consorzio
L’azione giudiziaria nasce da un’indagine avviata dalla Procura della Corte dei conti di Catanzaro, coordinata dal procuratore regionale Romeo Ermenegildo Palma e condotta dal sostituto procuratore generale Fernando Gallone. Le indagini sono state supportate dalla Guardia di finanza, che ha analizzato atti, finanziamenti e lavori eseguiti nel corso di oltre un decennio.
La Procura ha rilevato responsabilità precise nei confronti del Consorzio di bonifica ionio-catanzarese, chiamato a rispondere sia come ente sia attraverso le posizioni dei dirigenti che hanno guidato il progetto. Il procedimento mira a chiarire le ragioni che hanno portato alla revoca del finanziamento e a determinare se vi siano state negligenze o irregolarità nell’impiego delle risorse.
Gli inquirenti hanno posto attenzione anche ai contenziosi in corso con le imprese appaltatrici e alle dinamiche di progetto che non hanno rispettato le normative tecniche e ambientali. Sono in corso valutazioni per eventuali azioni risarcitorie a tutela del patrimonio pubblico. L’esito di questa procedura potrebbe diventare un caso di riferimento per le opere pubbliche in Calabria e per la gestione di fondi pubblici destinati a infrastrutture critiche.