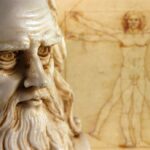La questione legata ai Pfas torna alla ribalta nel 2025, con un pronunciamento storico che collega direttamente queste sostanze chimiche alla morte di un operaio italiano. Per la prima volta, un tribunale ha riconosciuto un nesso causale tra l’esposizione a queste sostanze e una malattia fatale, aprendo nuove prospettive nel dibattito sulla sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica. L’attenzione si concentra anche sulle ripercussioni legali e ambientali in alcune province del Nord Italia.
Il caso pasqualino zenere, operaio della miteni e la sentenza del tribunale di vicenza
Nel territorio di Vicenza, un evento giudiziario ha stabilito un precedente importante. Pasqualino Zenere lavorò come operaio per la Miteni di Trissino, un’azienda attiva dal 1979 al 1992, specializzata nella produzione chimica. Zenere morì nel 2014 a causa di un tumore alla pelvi renale. I suoi eredi decisero di intraprendere un’azione legale contro l’Inail, citando proprio l’esposizione ai Pfas come causa della malattia.
Una sentenza storica per i pfas
Il tribunale di Vicenza, con una sentenza ritenuta storica, ha riconosciuto il legame diretto tra il lavoro in fabbrica e l’insorgere del tumore, attribuendo la colpa all’inquinamento da Pfoa e Pfos. Durante gli anni di lavoro, Zenere venne a contatto con queste sostanze, respirandole e ingerendole, elemento che la documentazione legale ha confermato in modo dettagliato. L’avvocato che ha seguito la vicenda ha sottolineato come questa sia la prima sentenza che affronta in modo specifico e con prove concrete il tema dei Pfas come causa di morte.
Altri sviluppi giudiziari sono in corso nel vicentino, dove 15 manager della Miteni devono rispondere di contaminazione ambientale. Le sostanze chimiche in questione avrebbero inquinato le falde acquifere e l’acqua potabile, interessando circa 350mila abitanti delle province di Vicenza, Padova e Verona.
Cosa sono i pfas e quali rischi comportano per la salute e l’ambiente
I Pfas – perfluorinated alkylated substances – si presentano come un gruppo di oltre diecimila composti chimici sintetici, molto resistenti e usati da decenni in vari prodotti industriali e di consumo. Il termine perfluorati indica alcune categorie di queste sostanze, apprezzate per le loro proprietà idrorepellenti e antiaderenti.
Questi composti però resistono a decomposizione e si accumulano nell’ambiente e negli organismi viventi. Numerosi studi hanno evidenziato come l’esposizione prolungata ai Pfas possa alterare vari sistemi del corpo umano: dal sistema immunitario a quello endocrino, influendo anche sui processi metabalici. Alcune ricerche suggeriscono che certi Pfas aumentino il rischio di sviluppare tumori a diversi organi.
Le sostanze si nascondono in oggetti di uso quotidiano, come tessuti antimacchia, spray impregnanti, cerotti per sportivi e contenitori per alimenti surgelati. Entrano nell’organismo anche attraverso l’acqua contaminata e la polvere domestica, rendendo difficile evitarle del tutto. Per esempio, un ruolo importante viene dato ai rivestimenti antiaderenti delle pentole, che a temperature elevate possono rilasciare composti dannosi.
I consumatori sono invitati a privilegiare materiali alternativi come vetro, ceramica o acciaio inox per la conservazione e il riscaldamento degli alimenti.
Quadro europeo e misure future
L’attenzione riguardo ai Pfas ha portato a una stretta normativa a livello europeo, con nuove restrizioni che entreranno in vigore nel 2026. Un’indagine condotta da Altroconsumo ha testato numerosi prodotti disponibili sul mercato italiano, rilevando che il 21% di questi contiene Pfas in quantità o tipologie non conformi agli standard previsti.
In particolare, il 24% degli articoli analizzati presenta alcune di queste sostanze, anche se ancora non dichiarate vietate dalle normative vigenti. Dal prossimo anno, però, 10 tipi di Pfas saranno messi al bando in prodotti come tovaglie, cuscini, cosmetici e imballaggi alimentari. Importanti cambiamenti interesseranno anche calzature, carta per alimenti e schiume antincendio, ambiti in cui finora poche restrizioni erano applicate.
Le misure mirano a contenere l’impatto ambientale e a salvaguardare la salute pubblica, rispondendo ai casi di inquinamento riportati in diverse parti d’Italia. Non cambia, però, la complessità della gestione degli scarti industriali e la necessità di monitorare l’effettiva applicazione di queste norme nel tempo.
Il riconoscimento giudiziario a Vicenza potrebbe spingere altre vittime e le loro famiglie a chiedere conto delle esposizioni subite, dando un rilievo nuovo ai controlli e agli interventi sul territorio.