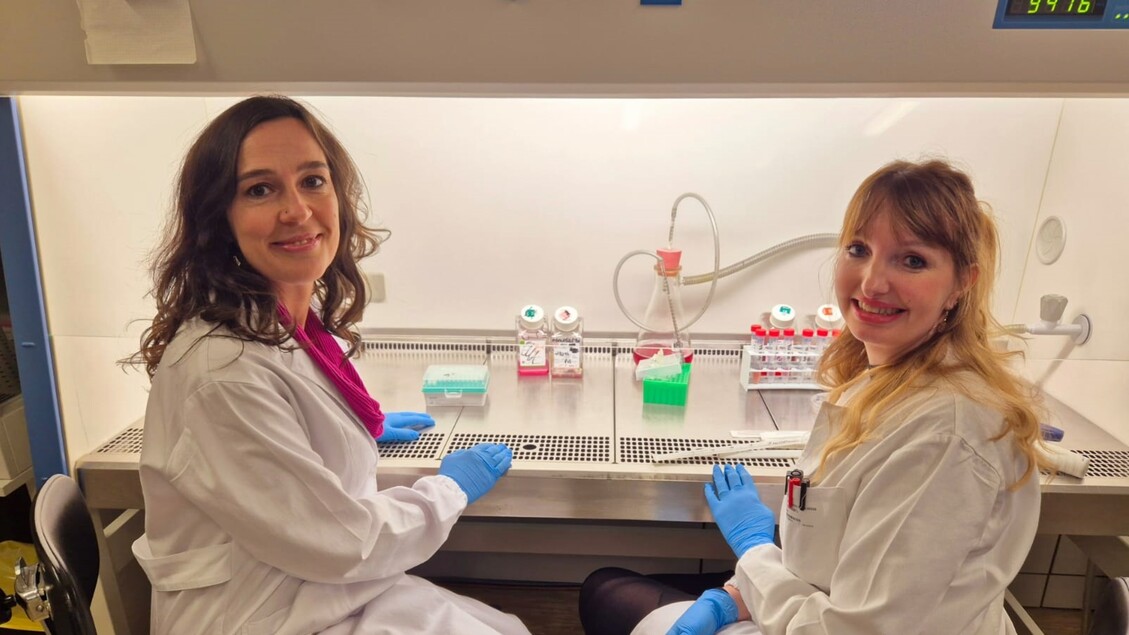Recentemente, una ricerca condotta dalla Struttura di Immunopatologia e Biomarcatori oncologici del CRO di Aviano, in provincia di Pordenone, ha attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Gli studi sono stati pubblicati sulla rivista “Journal of Experimental & Clinical Cancer Research” e si concentrano sul ruolo della proteina Spry1 nel melanoma cutaneo BRAF-mutato. Questa informazione potrebbe rappresentare un passo importante nella lotta contro questo tipo di tumore, che colpisce un numero crescente di pazienti ogni anno.
La mutazione BRAF e il suo impatto sul melanoma
Il melanoma cutaneo BRAF-mutato è una forma di cancro della pelle che coinvolge una mutazione nel gene BRAF, presente in circa il 50% dei casi di melanoma. Questa mutazione porta alla produzione di una proteina alterata, che rimane cronicanente attivata, contribuendo così alla proliferazione incontrollata delle cellule tumorali. Questo meccanismo è particolarmente insidioso, poiché consente al cancro di avanzare rapidamente e di diventare più difficile da trattare.
La ricerca della Struttura di Immunopatologia ha messo in evidenza come la comprensione molecolare di questi processi possa aprire nuovi orizzonti per le terapie. La scoperta che la proteina Spry1 è localizzata a livello dei mitocondri rappresenta una novità significativa. Le autrici dello studio, Elisabetta Fratta e Barbara Montico, hanno sottolineato l’importanza di questa scoperta, evidenziando come l’inibizione di Spry1 possa influenzare l’omeostasi mitocondriale. Questo significa che le cellule tumorali perdono la loro capacità di autoregolarsi e di mantenere un equilibrio interno, il che può portare all’accumulo di specie reattive dell’ossigeno, fenomeno collegato a un’ulteriore aggressività del tumore.
Il legame tra Spry1 e le risposte terapeutiche
Uno dei principali risultati dello studio è che l’inibizione di Spry1 non solo provoca un aumento delle specie reattive dell’ossigeno, ma porta anche a una diminuzione del metabolismo del glucosio. Questo aspetto è cruciale, poiché il glucosio è una fonte primaria di energia per le cellule, in particolare per quelle tumorali, che necessitano di grandi quantità di energia per crescere rapidamente. Riducendo il metabolismo del glucosio, si potrebbe limitare la capacità delle cellule tumorali di proliferare.
In parallelo, la ricerca ha anche dimostrato che l’azione su Spry1 si associa a una significativa diminuzione dell’angiogenesi, il processo mediante il quale il tumore forma nuovi vasi sanguigni. Questo processo è essenziale per la diffusione del cancro, poiché fornisce le risorse necessarie per il suo sviluppo. Una limitazione di questi vasi sanguigni potrebbe quindi risultare fondamentale per contrastare la progressione del melanoma, facendo di Spry1 un obiettivo terapeutico promettente.
Collaborazioni e supporto per la ricerca
Lo studio che ha portato a questi risultati è stato coronato da una serie di collaborazioni con importanti enti di ricerca e università. Tra i contributori figurano l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, le Università di Salerno e di Udine, il CNR di Bologna, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena e l’Ateneo di Oslo. Queste sinergie rappresentano un esempio concreto di come la ricerca oncologica possa avvalersi della collaborazione tra diverse istituzioni per raggiungere obiettivi ambiziosi.
Il lavoro è stato sostenuto anche dai fondi del 5×1000 Seed Grant e dal Ministero della Salute, a dimostrazione dell’impegno pubblico nel promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo di terapie innovative per il trattamento del cancro. Questi investimenti non solo favoriscono nuove comprensioni scientifiche, ma possono portare a interventi clinici più efficaci per i pazienti affetti da melanoma.
Questa ricerca rappresenta un passo importante per non solo aumentare le conoscenze sull’interazione tra la proteina Spry1 e il melanoma, ma anche per supportare ulteriori studi clinici che potrebbero tradurre queste scoperte in soluzioni terapeutiche concrete. La lotta contro il melanoma continua e, grazie alla ricerca, ci sono speranze di un futuro migliore per chi ne è colpito.