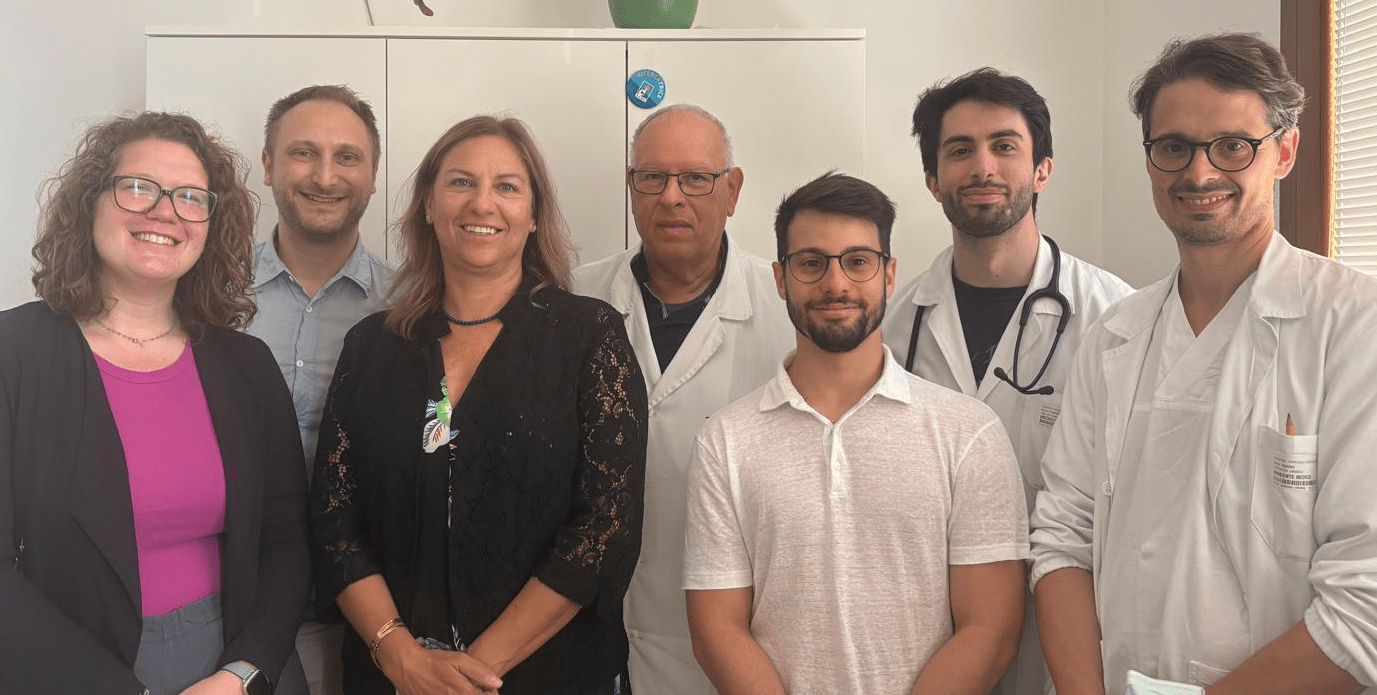La leucemia linfatica cronica resta una delle neoplasie ematologiche più diffuse, con varianti che presentano livelli diversi di aggressività. Un gruppo di ricercatori internazionali, coordinato dall’università di Padova, ha identificato specifici Rna circolari in grado di distinguere le forme più aggressive di questa malattia. Lo studio, pubblicato sul Journal of Hematology & Oncology, apre nuove prospettive per la diagnosi e la terapia personalizzata, puntando su molecole finora poco esplorate nel percorso oncologico.
La leucemia linfatica cronica e le molecole rna circolari
La leucemia linfatica cronica colpisce le cellule del sangue e presenta spesso un decorso variabile. Alcune forme, anche se meno numerose, risultano più aggressive e resistenti alle terapie tradizionali. La ricerca al centro di questo studio si è concentrata sugli Rna circolari, molecole di Rna che a differenza dei tradizionali Rna lineari presentano una struttura chiusa a cerchio. Questi Rna sono ancora poco conosciuti ma appaiono promettenti come biomarcatori per individuare tumori con caratteristiche specifiche.
Attraverso un’analisi dettagliata del trascrittoma circolare, i ricercatori hanno esaminato campioni provenienti da pazienti affetti da una rara forma aggressiva di Cll, che rappresenta circa l’1% dei casi diagnosticati. L’obiettivo era capire se specifici Rna circolari potessero collegarsi a segni di aggressività, come alterazioni cromosomiche che causano aumentata produzione della proteina Bcl3, nota per il suo ruolo nella progressione tumorale.
Leggi anche:
Due molecole in particolare, denominate circCoro1C e circClec2D, sono risultate elevate nelle cellule leucemiche più aggressive. Questo aumento suggerisce che possano essere usate come marker per predire la gravità della malattia e monitorarne l’evoluzione, una strategia diagnostica che potrebbe diventare cruciale nel futuro prossimo.
Metodi e collaborazioni internazionali dietro la ricerca
La complessità del progetto ha richiesto il coinvolgimento di 28 centri di ricerca e ospedali in 12 diversi Paesi, tra cui Svezia, Grecia, Stati Uniti e Cina. Il coordinamento scientifico è stato affidato ai laboratori dell’università di Padova, in particolare alle unità di Medicina computazionale, Ematologia e Biologia molecolare. La raccolta di campioni e le analisi comparative sono state effettuate mettendo a confronto le cellule tumorali aggressive con forme più comuni di leucemia e cellule sane del sistema immunitario.
Le tecniche usate comprendono sequenziamento avanzato e algoritmi sofisticati di bioinformatica, necessari per distinguere gli Rna circolari da quelli lineari e quantificarli nei differenti gruppi di pazienti. L’uso di queste tecnologie ha permesso un’indagine precisa e senza precedenti che ha svelato la presenza massiccia di alcuni Rna circolari nelle cellule cancerose.
Il ruolo dei giovani ricercatori Eleonora Roncaglia ed Enrico Gaffo è stato fondamentale per condurre parte dell’analisi pionieristica legata all’applicazione di farmaci a Rna, ambito nel quale si stanno sviluppando nuove terapie mirate proprio contro quelle molecole considerate “segnali” della malattia aggressiva. Dietro il lavoro c’è anche il sostegno di programmi europei come il Pnrr e diversi enti di ricerca nazionali, un segno della grande attenzione rivolta al tema da parte della comunità scientifica.
Possibili impatti clinici ed evoluzione futura della terapia
L’identificazione di circCoro1C e circClec2D come marcatori di aggressività apre scenari per una diagnosi più tempestiva e puntuale della leucemia linfatica cronica. In particolare, l’orientamento verso terapie che sfruttano Rna circolari come bersagli potrebbe andare a potenziare l’arsenale terapeutico, soprattutto per quei pazienti con forme difficili da trattare.
La scoperta rende plausibile lo sviluppo di farmaci a Rna che mirano a ridurre o modificare la produzione della proteina Bcl3, la cui sovraespressione è associata all’aggressività della malattia. In questo senso, lo studio dell’università di Padova e collaboratori può rappresentare uno snodo importante per la medicina di precisione applicata alla Cll.
Il ruolo dell’università di padova e dei finanziatori nel progetto
Il laboratorio del Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’università di Padova ha svolto un ruolo centrale, alla guida sia delle analisi molecolari sia del coordinamento internazionale. La collaborazione con l’Unità di Ematologia dell’ateneo e con il Centro nazionale di terapia genica e farmaci a Rna ha impresso una forte spinta al progetto.
Il finanziamento è arrivato da più fonti: l’ateneo stesso con il progetto Stars, la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, il Pnrr dedicato allo sviluppo di farmaci a Rna e la ricerca su Biomedicina computazionale. Fondamentale anche il sostegno di associazioni come “Ricerca per credere nella vita”, che nasce dal coinvolgimento diretto di pazienti e famiglie. Questo insieme di risorse ha permesso di realizzare uno studio complesso e innovativo, espressione di una rete collaborativa tra pubblico e privato e fra diverse discipline scientifiche.
La pubblicazione sul Journal of Hematology & Oncology proietta questo lavoro nel panorama internazionale delle scoperte oncologiche, portando l’attenzione sulle potenzialità degli Rna circolari come strumenti clinici e terapeutici. L’impegno degli scienziati resta orientato a migliorare la qualità della diagnosi e la risposta terapeutica, a beneficio di chi affronta questa malattia.