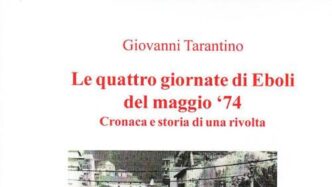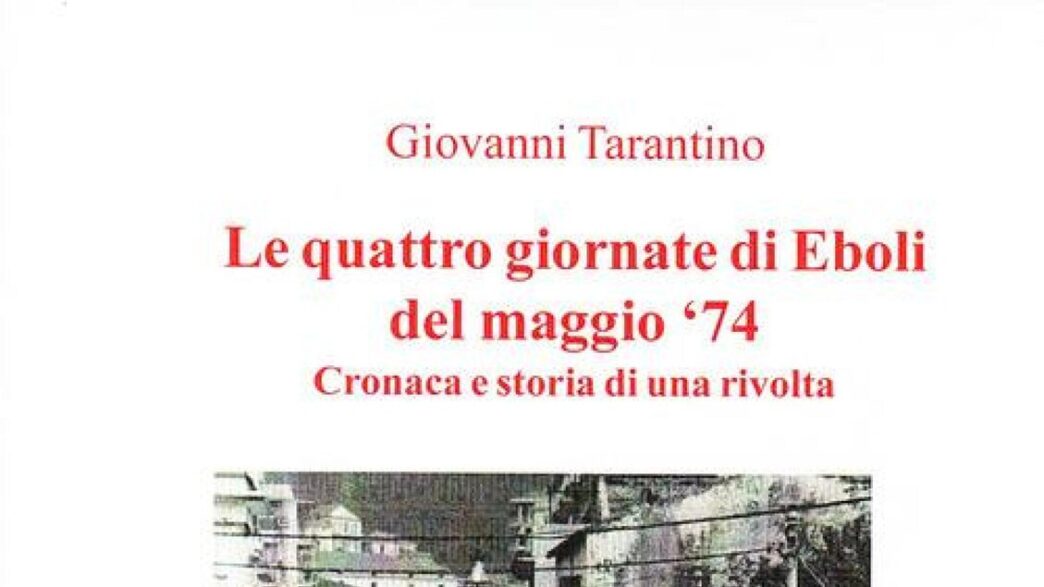Negli anni Settanta, il Sud Italia viveva una crisi economica profonda e le tensioni sociali si manifestavano con forza. Tra queste emerge l’episodio delle Quattro Giornate di Eboli, una protesta civile che esprimeva la rabbia di un territorio tradito nelle sue aspettative di sviluppo. Quel maggio del 1974, la decisione politica di spostare un grande insediamento industriale portò la popolazione a mobilitarsi con determinazione. Il libro di Giovanni Tarantino ripercorre questi eventi cercando di far riaffiorare un capitolo poco ricordato ma decisivo nel Mezzogiorno.
Il contesto politico e sociale in italia nel maggio 1974
L’Italia stava attraversando un periodo segnato da forti divisioni ideologiche e tensioni politiche. Si avvicinava il referendum sul divorzio, che avrebbe polarizzato ulteriormente l’opinione pubblica. In più, l’intervento delle Brigate Rosse si faceva sentire con azioni drammatiche come il sequestro del giudice Mario Sossi a Genova. In tutto questo fermento, il Sud continuava a faticare, afflitto dal mancato sviluppo industriale e dall’alta disoccupazione, soprattutto giovanile. Il Salernitano, nonostante le promesse elettorali della Democrazia Cristiana, subiva ancora gli effetti di politiche inefficaci. La Cassa per il Mezzogiorno, pur attiva, non riusciva a restituire lavoro stabile ad ampie fasce della popolazione.
Il mancato insediamento di grandi industrie sul territorio aveva creato frustrazione. La Piana del Sele rappresentava una delle aree più fertile e produttive, eppure non veniva valorizzata con investimenti concreti. I rilievi politici dell’epoca parlavano di opportunità sprecate e opportunismi. È in questo quadro che dal 4 all’8 maggio si verificò quella protesta pacifica ma decisa che avrebbe segnato la memoria locale e che Giovanni Tarantino, con il suo lavoro, ha voluto riproporre. Quel tempo così carico di tensioni, economicamente difficile e politicamente complicato, spiegano tante delle ragioni della mobilitazione.
Leggi anche:
Le cause della protesta: la decisione del cipe e le promesse tradite
La scintilla che innescò le Quattro Giornate fu l’annuncio da parte del Cipe, guidato all’epoca dal ministro Ciriaco De Mita, di spostare un insediamento industriale della Fiat dalla Piana del Sele a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Per gli abitanti di Eboli fu una nuova umiliazione, dopo un caso analogo con l’Aeritalia, destinata a Foggia invece che al Salernitano. Quel trasferimento significava la perdita di 3000 posti di lavoro e investimenti per 65 miliardi di lire, cifre notevoli per la realtà economica locale.
Nei giorni seguenti, l’indignazione crebbe rapidamente. Il passaparola portò alla mobilitazione spontanea di migliaia di persone. Le proteste furono scandite da scioperi generali, blocchi delle ferrovie e occupazioni di strade come la Salerno-Reggio Calabria. Anche se la tensione si alzò notevolmente, a differenza di altre manifestazioni della zona, come quelle di Battipaglia del 1969, qui non si contarono vittime né scontri violenti con le forze dell’ordine, salvo un episodio isolato legato all’incendio di un rapido alla stazione.
Quel momento rappresentava dunque una protesta non armata ma decisa. La comunità locale comunicava una protesta civile che voleva mettere in luce le disuguaglianze territoriali e un modello di sviluppo che continuava a ignorare il Sud. Il corteo di eventi di quei giorni testimonia come l’economia e la politica fossero strettamente legate e come le scelte politiche potessero influire profondamente sulle condizioni di vita dei cittadini.
Le conseguenze politiche e la mobilitazione sindacale nel salernitano
Dopo la protesta, il governo rispose con nuove promesse: sarebbe arrivato uno stabilimento della Sir con 3300 posti di lavoro a sostituire quello della Fiat. Anche questa soluzione però non si concretizzò mai. Un progetto fallito in anticipo, che avrebbe inoltre rischiato di danneggiare il territorio, che rimaneva una delle terre più fertili e pregiate della regione. Il libro di Tarantino mette in luce proprio questo aspetto spesso trascurato: dietro alle promesse mancate c’erano anche ragioni ambientali e di tutela del territorio, ignorate nelle dinamiche politico-industriali.
Un elemento importante nella narrazione riguarda il ruolo del sindacato e della società civile. Cgil, Cisl e Uil, insieme ai metalmeccanici, rappresentarono un fronte unito che provava a tenere vivi ideali di collaborazione tra operai e contadini. L’unità si richiamava a quanto teorizzato da Gramsci, con l’obiettivo di superare il divario economico tra Nord e Sud. Quel movimento di protesta rappresentava quindi anche un tentativo di costruire un legame tra le classi sociali, di approfondire temi di giustizia sociale e sviluppo sostenibile.
La memoria storica delle quattro giornate ricostruita da giovanni tarantino
Il movimento però non ebbe continuità e finì per testimoniare l’ultimo sussulto di un Mezzogiorno rimasto al margine dei processi decisionali. L’ex sindaco di Eboli Gerardo Rosania ha sottolineato come la questione meridionale fosse destinata a cambiare volto con l’avvento dell’autonomia regionale differenziata, che avrebbe ridotto ulteriormente la centralità del Sud nel dibattito nazionale. Il sogno industriale ebolitano si spense insieme a quella protesta, lasciando una memoria che resta da rileggere con attenzione.
Giovanni Tarantino, allora giovane impegnato nella politica e in seguito sindacalista e dirigente nelle istituzioni, affronta in modo dettagliato la ricostruzione di quei giorni decisivi. Il suo volume mette ordine tra i documenti, ascolta le testimonianze dei protagonisti e cerca di far emergere i conflitti, le speranze e le delusioni di una stagione politica intensa. Cinquant’anni dopo, questo racconto vuole restituire dignità a un episodio troppo spesso marginalizzato o dimenticato.
Attraverso una narrazione che alterna contributi diretti e analisi storica, il libro offre un punto di vista che evita facili idealizzazioni e invece racconta l’evento nel suo aspetto più complesso. La protesta di Eboli fu un momento di partecipazione civile e confronto sociale, senza ricorrere alla violenza, che tuttavia evidenziò le contraddizioni politiche dell’Italia del tempo. Il testo diventa così uno strumento per chi vuole capire meglio il passato e magari trovare spunti per affrontare le sfide attuali, specie in un Mezzogiorno ancora a caccia di lavoro e futuro.