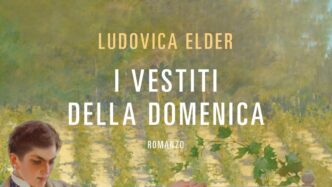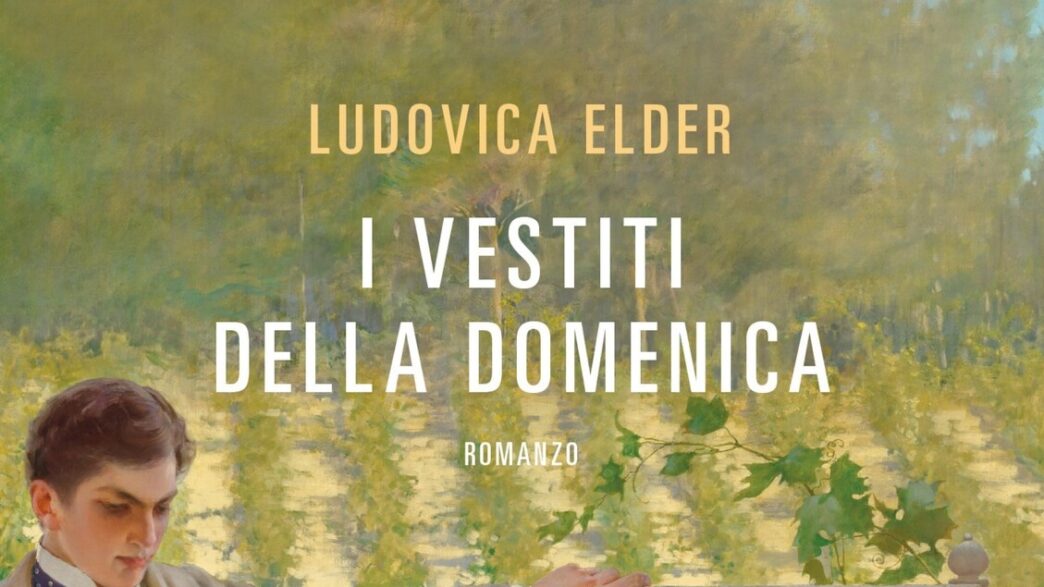La vicenda dei Stefàncich, al centro del romanzo “i vestiti della domenica” di Ludovica Elder, racconta un pezzo d’Italia poco conosciuto ma fondamentale per la storia. Tra Trieste, Monfalcone e le colline del Carso si sviluppa una narrazione che attraversa il passaggio dalla dominazione asburgica all’ascesa del fascismo, con le sue tensioni sociali e politiche. Il romanzo scava nei legami familiari e negli intrecci fra classi diverse, offrendo uno spaccato della società di quegli anni attraverso i personaggi di una famiglia di imprenditori appena diventati possidenti.
La trasformazione della famiglia Stefàncich e l’ascesa economica nel porto di Monfalcone
La storia prende avvio con la crescita della famiglia Stefàncich, che da modesti inizi come lavoratori nel trasporto riesce a elevarsi al rango di proprietari terrieri in poco tempo. L’impresa di trasporti fondata dal padre di Vittorio, protagonista della storia, ottiene successo grazie alla posizione strategica vicino al porto e al cantiere navale di Monfalcone. Questa nuova ricchezza permette alla famiglia di acquisire terre, migliorare la casa e ampliare le attività legate al commercio col mare Adriatico. Vittorio emerge come il primogenito destinato a guidare l’azienda, destinato a un percorso di studio e prestigio mai visto prima tra i suoi.
Gli abiti eleganti, che Vittorio indossa non solo di domenica, rappresentano simbolicamente il salto sociale raggiunto. Questa trasformazione si svolge in un contesto in cui Trieste e il Carso vivono i contrasti fra una realtà ancora segnata dal dominio austriaco e l’irrompere di nuovi poteri nazionali. Il tessuto sociale qui è variegato, spaziando da ricchi borghesi a contadini e operai, e crea un quadro complesso che si riflette nelle scelte e nei destini della famiglia Stefàncich.
Leggi anche:
Il coraggio di Vittorio e il conflitto di fedeltà durante la prima guerra mondiale
Vittorio entra nella storia militare arruolandosi nella regia marina asburgica, ma quando l’Italia entra in guerra contro l’Austria prende una decisione rischiosa e significativa: diserta per unirsi all’esercito italiano. Questo gesto espone a gravi pericoli, compresa la fucilazione in caso di cattura, ma testimonia la complessità dell’identità di quella zona di confine. Vittorio mostra così un coraggio concreto, ricevendo il congedo con onore alla fine del conflitto.
Al suo ritorno fatica a elaborare le ferite di guerra, quella condizione che oggi si chiamerebbe disturbo post-traumatico da stress. L’esperienza militare lascia segni nella psiche del protagonista, ma apre anche la strada a nuove possibilità. Vittorio si tuffa nell’impresa di famiglia, riscoprendo la vita civile e un ruolo da uomo d’affari, tra sfide e conquiste quotidiane. La sua storia combina dunque il dramma personale con la trasformazione di un’epoca.
Antonia Pàhor e il mosaico culturale di Trieste e del Carso
Antonia Pàhor incarna un’altra dimensione di questo racconto radicato nel confine orientale d’Italia. Figlia di proprietari di vigne sull’altopiano del Carso, conosce da subito la complessità di un territorio multilingue, dove italiano e sloveno convivono. La sua educazione, che comprende studi superiori a Trieste, la porta a entrare in contatto con la città e il suo ambiente fatto di mare, palazzi antichi e vento di bora, elemento caratteristico del luogo.
Antonia vive in prima persona gli attriti sociali, soprattutto nel rapporto con chi, come lei, si muove tra un ceto medio e la nobiltà emergente. La sua amicizia con Vittorio si intreccia con conoscenze di altri personaggi, come Giacomo Ledri, un giovane spregiudicato che sceglie la scalata politica nel fascismo. In questa zona il confine tra identità nazionale e alleanze politiche si fa spesso sottile. La figura di Antonia permette di guardare anche a chi vive in una condizione meno agiata, costretto a confrontarsi con un mondo diviso, culturalmente e socialmente.
Le tensioni politiche e la presa del potere fascista nella Venezia Giulia
Il romanzo descrive con precisione quello che succede il 28 ottobre 1922, quando il fascismo si insedia nella regione senza grandi resistenze. A Trieste squadre di fascisti armati camminano verso la prefettura, occupandola senza scontri rilevanti. A Monfalcone la presa dei simboli amministrativi avviene senza bisogno di azioni violente. Questa facilità nel conquistare il potere locale rivela una mancanza di opposizione organizzata, causata dalla confusione politica e dall’assenza di strategie efficaci tra chi avrebbe potuto contrastare il regime.
I protagonisti del romanzo vivono un momento storico di sospensione, in cui felicità, paura e speranze si mescolano. La narrazione si ferma prima che l’autoritarismo e la guerra inizino a modificare radicalmente le loro vite. Questo racconto disegna un quadro in cui la storia nazionale si incrocia col destino quotidiano delle persone comuni, mostrando le ambiguità e le sfide di un periodo cruciale per il nordest italiano.