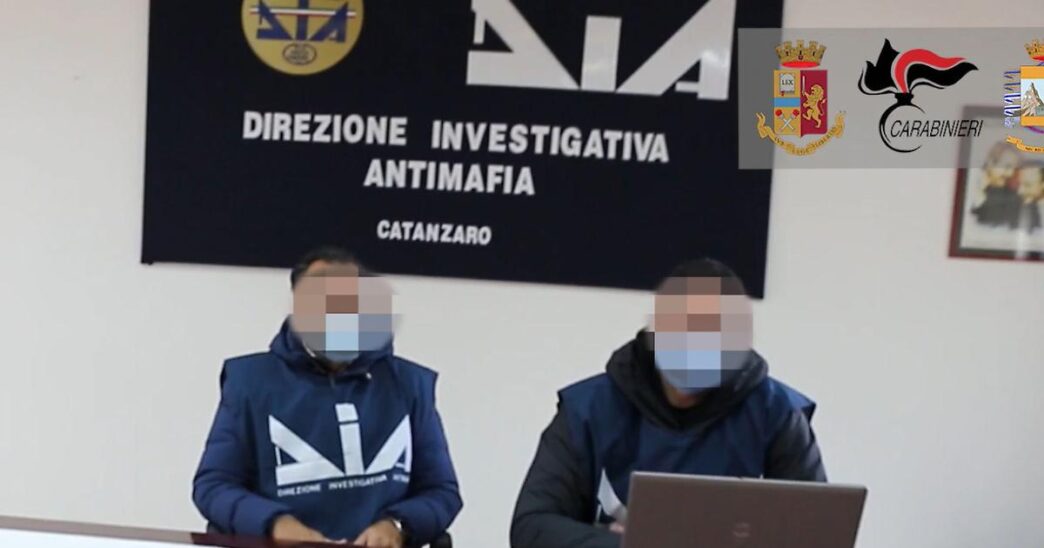La relazione annuale 2024 della Direzione Investigativa Antimafia ha fotografato i cambiamenti profondi nel modo in cui si strutturano le organizzazioni mafiose in Italia. Le consuete guerre tra clan e il dominio territoriale non sono più al centro dell’azione criminale. Al loro posto, si profilano alleanze trasversali, un’economia parallela e infiltrazioni diffuse nelle attività legali e nei gangli dell’amministrazione pubblica. Il rapporto presentato a Roma evidenzia quanto i gruppi mafiosi abbiano trasformato il crimine in una rete imprenditoriale, con ramificazioni che oltrepassano confini regionali e settoriali.
La collaborazione tra cosche di diverse regioni e culture criminali
Un aspetto centrale emerso nella relazione DIA riguarda la capacità dei clan di superare tradizioni e barriere storiche. Il traffico di droga si conferma terreno di cooperazione, come dimostra l’alleanza tra Cosa nostra gelese e la ‘ndrangheta calabrese. Due realtà che una volta operavano isolatamente hanno scelto di condividere rotte, fornitori e profitti. Nel Piemonte, poi, si segnala una partnership tra ‘ndranghetisti e componenti della comunità sinti, impegnati nel reperimento e nella custodia di armi da fuoco da immettere sul mercato illegale. Questi legami indicano come le mafie puntino a combinare risorse e competenze differenti per consolidare il loro potere criminale.
La relazione descrive queste intese come patti utilitaristici. Non si tratta più di lotte frontali per la supremazia territoriale, ma di un mosaico in cui ogni parte contribuisce a mantenere attiva e redditizia l’attività illecita. L’approccio si basa su una logica condivisa del profitto, che ha portato a forme di governance mafiosa più fluide e adattive. Diventa evidente come l’interconnessione tra gruppi sia uno strumento efficace per superare controlli e azioni investigative concentrate solo su singole realtà locali.
Leggi anche:
Infiltrazioni nel tessuto economico e nelle pubbliche amministrazioni
La mafia contemporanea manifesta una capacità crescente di insinuarsi nelle attività economiche legali. La DIA ricorda la crescente presenza della ‘ndrangheta nel settore degli appalti pubblici, nella raccolta rifiuti, nelle aziende ospedaliere. Qui si esercita il controllo sulle forniture, sulle aziende subappaltatrici e sulle autorizzazioni, con una pressione costante sulle amministrazioni coinvolte. La penetrazione avviene con discrezione, sfruttando collusioni e scambi di favori per ottenere concessioni tramite canali ufficiali.
Gli elementi di infiltrazione sono documentati in vari territori dove i clan hanno conquistato posizioni su appalti e concessioni pubbliche. Non si limitano a condizionare attività economiche marginali, ma puntano a operazioni con elevati volumi finanziari. Il loro agire passa per il sistema amministrativo, dove spesso si intercettano pratiche opache che consentono di aggirare i controlli. La DIA sottolinea come la corruzione e le connivenze tra funzionari e imprenditori siano fattori chiave per il radicamento nei circuiti economici legali.
Dati sulle operazioni della dia e il fenomeno della connivenza economica
Nel 2024 la DIA ha fatto sequestri per quasi 160 milioni di euro, una somma che riguarda soprattutto Cosa nostra e la camorra campana. Le indagini portate a termine sono state 53, mentre i provvedimenti restrittivi hanno superato quota 300. Tuttavia la relazione evidenzia che questi numeri rappresentano solo la parte “visibile” del fenomeno. Una quota decisiva dell’attività criminale si svolge dietro le quinte, nascosta tra operazioni finanziarie e documenti fiscali.
Il rapporto mette in luce l’esistenza di una rete di complicità tra imprenditori e clan. La corruzione non è sempre subita, ma talvolta si trasforma in accordi che rendono conveniente l’infiltrazione mafiosa. Le tangenti diventano fatture false, che vengono integrate nel sistema contabile e scaricate fiscalmente. In questo modo, l’estorsione si trasforma in una voce di costo ammissibile e l’adesione al sistema criminale diventa un’opzione praticabile per mantenere o ottenere vantaggi nel mercato.
Questa rete di connivenze mina la concorrenza e altera le regole economiche, modificando il comportamento delle imprese sul territorio. Non si tratta di sofisticazioni isolate, ma di un fenomeno radicato che coinvolge vari livelli della catena produttiva e distributiva. La mafia opera dunque anche come un “partner” economico occulto, che interferisce con la crescita e l’equità del mercato nazionale.
La mafia come impresa, i nuovi metodi di comando e il monito della relazione dia
La trasformazione delle organizzazioni mafiose in imprese criminali segna un cambiamento di strategia evidente. I boss non puntano più a imporsi con la violenza diretta o la paura ma lavorano per legittimarsi nelle comunità. Investono nel settore legale, acquisiscono aziende, partecipano a progetti pubblici presentandosi come imprenditori rispettabili. Il loro metodo di comando si basa su trattative, finanziamenti e corruzione, e non più su sparatorie o intimidazioni plateali.
Questa metamorfosi rende più difficile scovare e bloccare le attività illecite. I nuovi capi puntano soprattutto a infiltrarsi e a condizionare ambienti economici e istituzionali. La relazione DIA va oltre la semplice denuncia e lancia un appello alle istituzioni, chiedendo una risposta centralizzata e integrata. Occorre una collaborazione stretta tra intelligence, forze dell’ordine, magistratura e anche enti fiscali e professionali. Gli interventi devono adattarsi a una minaccia che ha mutato e ampliato i propri orizzonti.
Il rapporto mette in guardia rispetto al divario tra l’evoluzione criminale e gli strumenti attuali delle forze di polizia, che rischiano di restare ancorati a strategie superate. La mafia ha ormai trasformato il suo campo di battaglia: il sistema economico e le reti di potere locale e internazionale. Il rischio è che il contrasto resti inefficace se non affronta la mentalità di tolleranza, il mercato complice, e l’atteggiamento di chi preferisce non vedere.