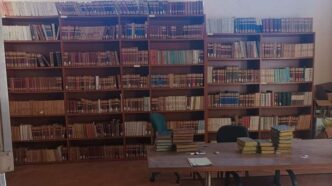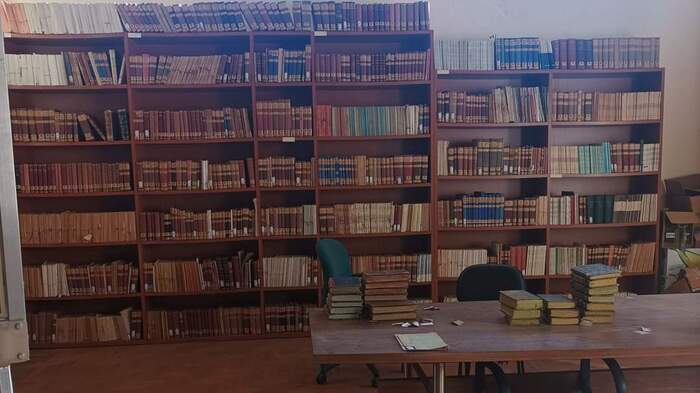Il 49° congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina si svolge oggi a Salerno, dove un tema interessante si affaccia all’orizzonte delle discussioni. Tra le varie sessioni, spicca la presentazione di un articolo raro, risalente al 1924, che esplora la correlazione tra il cinematografo e lo sviluppo di malattie nervose e mentali in giovane età. Questo studio, custodito nella biblioteca del manicomio di Nocera Inferiore e redatto dallo psichiatra Guglielmo Mondio, offre una peculiare visione storica su come il cinema fosse percepito come un potenziale pericolo per i giovani dell’epoca.
Il ritrovamento del manoscritto storico
L’articolo di Mondio è stato recuperato da un gruppo di archiviste professioniste, collocato all’interno della Fondazione Cerps. Francesca Donato, una delle archiviste, ha spiegato all’ANSA come questo scritto analizzasse i comportamenti di dodici adolescenti inseriti in contesti familiari problematizzati. Questi ragazzi, costretti alla internazione nel manicomio di Messina per presunte dipendenze dal cinema, ci offrono uno spaccato della vita e delle problematiche sociali del tempo. Sebbene il campione di adolescenti studiato non presenti una robusta base statistica, la peculiarità del soggetto all’epoca ha una rilevanza che sconfina nel contemporaneo dibattito sui disturbi giovanili legati alla tecnologia e a internet. Questo parallelismo tra ieri e oggi fa riflettere sulle modalità di controllo sociale e sulle percezioni del comportamento giovanile nel corso del tempo.
I comportamenti giovanili al cinema: un’analisi profonda
Secondo Mondio, molti dei ragazzi esaminati avevano alle spalle storie familiari drammatiche. In effetti, il profilo socio-economico dei soggetti analizzati evidenziava situazioni di degrado, con la presenza di padri alcolisti e madri affette da gravi problematiche psichiche. Tra i ragazzi, Francesco B., di soli 12 anni, è descritto mentre frequenta il cinema con i suoi compagni di ginnasio. Le relazioni tra di loro si intensificavano, con la tendenza a ripetere in gruppo le scene degli spettacoli visti. Questo comportamento influisce negativamente sul rendimento scolastico e mostra già i segni di una dipendenza crescente: un tema che riesce a comunicare il desiderio di evadere da una realtà difficoltosa. Le osservazioni di Mondio non si limitano solo a Francesco, ma abbracciano anche il caso di due sorelle, Concetta e Laura, che vennero arrestate per comportamenti indecenti durante una delle loro visite al cinematografo.
Leggi anche:
La rappresentazione femminile e l’impatto sociale
Un aspetto cruciale sottolineato nello studio riguarda la rappresentazione delle donne nel cinema dell’epoca. Queste eroine, spesso ritratte come libere e senza pudori, influenzavano pesantemente il comportamento delle giovani spettatrici. Mondio notò come queste rappresentazioni potessero portare a comportamenti considerati libertini, mostrando il conflitto tra una società conservatrice e la modernità emergente. Le storie raccontate sullo schermo sembravano incitare le ragazze a cercare affetti nei coetanei, in contrasto con le norme sociali prevalenti. Questo cambiamento culturale portò inevitabilmente a frizioni sociali, rendendo la figura maschile potenzialmente pericolosa nei confronti della libertà femminile. Inoltre, nel caso di Tilde, un particolare fatto di cronaca, scaturito da una gelosia malsana, culmina in un omicidio che testimonia l’impatto devastante che i sentimenti influenzati dal cinema potevano avere in contesti già fragili.
L’emanazione delle problematiche psichiche
L’analisi finale di Mondio giunge a conclusioni preoccupanti riguardo all’impatto del cinema sulla psiche giovanile. Per lui, il cinematografo rappresentava una vera e propria fonte di danno, non solo a livello individuale, ma anche per la società nel suo complesso. Le testimonianze di ragazzi afflitti da allucinazioni e disturbi psichici evocano una realtà in cui il cinema è visto come un fattore di destabilizzazione. Questo punto di vista rivela una mancanza di comprensione delle sfide che i giovani affrontano e getta luce sulle rigidità sociali di un’epoca in rapida evoluzione. La storia di questi adolescenti, costretti tra desideri di libertà e normative oppressive, fa emergere domande ancora rilevanti per come trattiamo le esperienze giovanili e le loro espressioni in una società modernizzata.