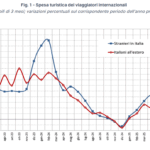La nuova edizione di “Ali di piombo”, scritto da Concetto Vecchio e recentemente ripubblicato da Utet, offre una visione ricca e sfaccettata del 1977 in Italia. Questo periodo, definito dal sottotitolo del libro “tragico e appassionato“, rappresenta un capitolo cruciale della storia italiana, caratterizzato da violenza politica e tensioni sociali. Vecchio, noto per il suo approccio investigativo e per la sua carriera come giornalista, intreccia narrazioni personali e fattuali per ricreare il clima di un’epoca complessa.
L’approccio di Concetto Vecchio
Concetto Vecchio, scrittore e giornalista de La Repubblica, si distingue per il suo modo di esplorare temi di rilevanza sociale. La sua metodologia si basa su interviste e testimonianze, e nel caso di “Ali di piombo”, ha raccolto le voci di ben 38 testimoni. Queste interviste forniscono non solo un resoconto degli eventi drammatici degli anni di piombo, ma si muovono anche su territori meno noti: le riforme sociali, le innovazioni artistiche e il nascente panorama del giornalismo. Il riferimento all’emergere di Repubblica e alla sua evoluzione offre uno spaccato di come il giornalismo stesso abbia affrontato e rappresentato il tumulto di quei tempi.
Le parole di Vecchio trasmettono un forte senso di responsabilità: “Il giornalismo è andare nei posti, col taccuino in mano, con più domande che risposte.” Questo approccio, che implica una presenza attiva sul campo, è fondamentale per comprendere le dinamiche del 1977, un anno in cui la violenza permeava la vita quotidiana e le storie individuali si intrecciavano in un arazzo complesso di esperienze.
Leggi anche:
Storie di tragedia e resilienza
L’opera mette in luce con tenerezza ed incisività le storie di coloro che hanno subito direttamente la violenza. Vecchio racconta della vita stravolta di Carlo Casalegno, un giornalista assassinato dalle Brigate Rosse, attraverso la testimonianza della vedova Dedi Andreis. La narrazione si sposta poi su Antonio Cocozzello, un semplice cittadino lombardo colpito in un agguato, e su Francesco Lorusso, simbolo delle violenze avvenute durante le manifestazioni. Queste storie personali offrono un’umanizzazione del conflitto, trasformando le statistiche in volti e destini.
Il libro di Vecchio non è solo un racconto di dramma, ma diventa anche una riflessione sulle conseguenze sociali di tali atti. Attraverso i racconti degli intervistati, emerge un’immagine complessa di una società sofferente, segnata dal dolore ma anche dalla resilienza. I dettagli delle loro esperienze arricchiscono il racconto, mostrando come la brutalità del terrorismo influisse non solo sulle vittime, ma anche su tutta la comunità.
La Torino del 1977 e il clima di indifferenza
Uno dei passaggi salienti del libro riguarda la situazione a Torino, epicentro di una violenza che divenne quasi normale. Concetto Vecchio riporta le parole di Patrizio Peci, il primo pentito delle Brigate Rosse, descrivendo una città che, colpita dai terroristi, pareva rimanere indifferente davanti al terrore. Le sue parole, “A Torino i ferimenti sono stati più che in qualsiasi altra città d’Italia,” dipingono una realtà in cui la gente aveva finito per accettare una convivenza con la violenza che risultava surreale.
Questo clima di rassegnazione fa emergere una questione cruciale: come reagire di fronte all’inevitabile? Vecchio discute questo aspetto attraverso incidenti e testimonianze che rivelano non solo l’indifferenza pubblica ma anche la modalità di scelta dei bersagli da parte delle BR, che prediligono vittime “facili” e meno protette, suggerendo una logica di azioni senza un vero ragionamento politico.
L’epilogo di un’epoca complessa
Nel finale del libro, l’autore mette in discussione il movimento del ’77, un fenomeno che ha portato alla luce non solo conflitti ma anche creatività. Il giudizio di Vecchio, tuttavia, si rivela critico: il movimento è ricordato “soprattutto per immagini di lutti e violenze.” Queste parole ci chiedono di considerare non solo la faccia oscura degli eventi ma anche le aspirazioni autentiche di chi, in quel periodo, cercava una via alternativa al status quo.
La chiusura dell’opera, arricchita da riflessioni personali, rivela una presa di coscienza profonda non solo sul terrorismo, ma sull’umanità delle persone coinvolte. Il peso dell’insensatezza del terrorismo emerge con forza, presentando un quadro duraturo di perdita e struggimento.
Con queste narrazioni intime e storicamente significative, Vecchio offre al lettore l’opportunità di comprendere a fondo uno dei periodi più tumultuosi della storia italiana, rendendo le voci dimenticate di quel tempo nuovamente udibili.