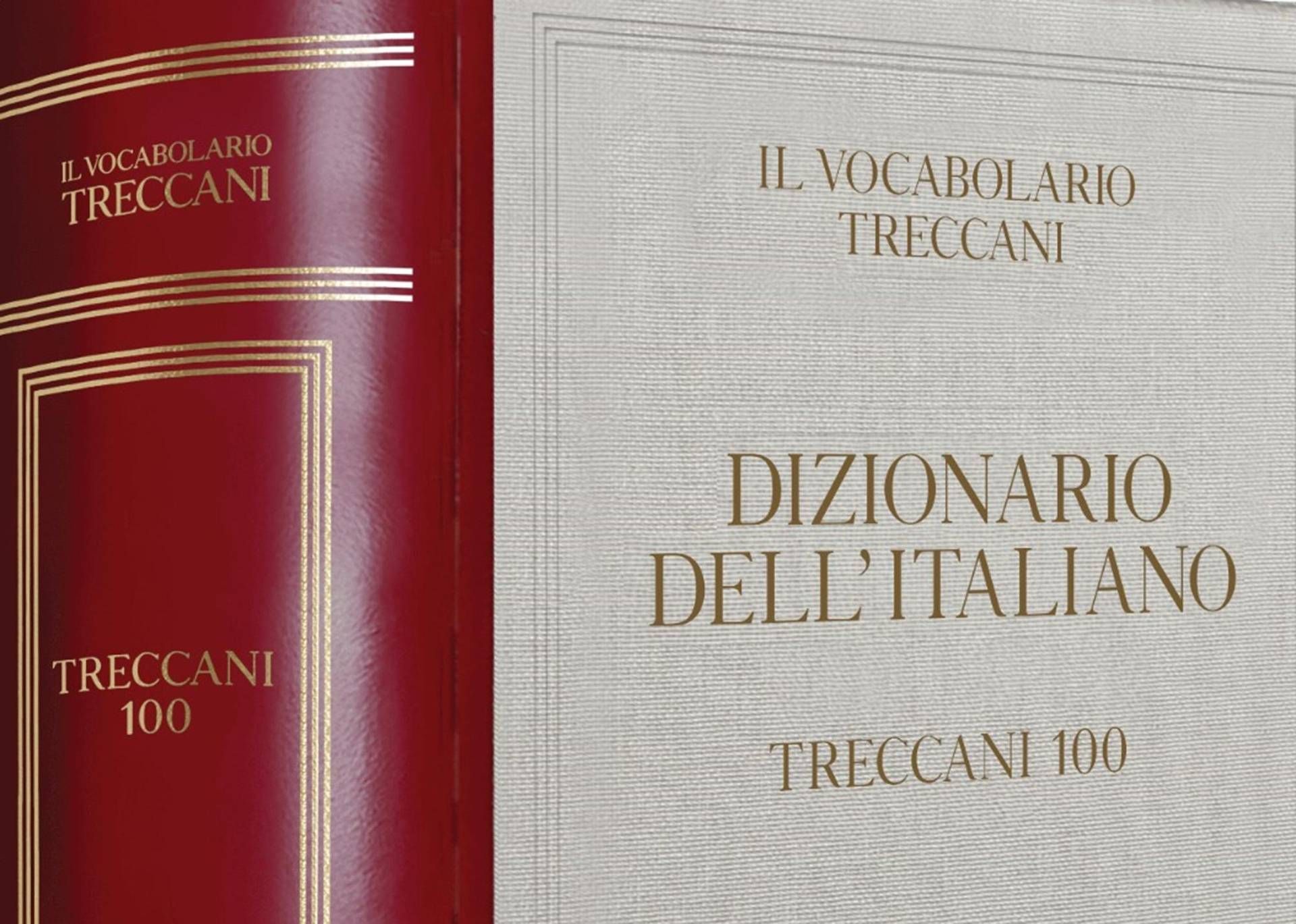Parlare del corpo non è mai stato neutro. Le parole che scegliamo per descrivere l’aspetto fisico riflettono la nostra cultura e influenzano i rapporti tra le persone. Nel 2025, il tema del body shaming resta centrale soprattutto in un contesto social sempre più esposto a giudizi e critiche sull’immagine. Il nuovo dizionario dell’italiano Treccani 100, curato dai linguisti Valeria della Valle e Giuseppe Patota, affronta questo argomento segnalando termini offensivi ma anche suggerendo alternative linguistiche più rispettose. Parallelamente, la politica italiana punta a un intervento concreto introducendo una giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico.
Il ruolo del dizionario nella trasformazione del linguaggio quotidiano
I ragazzi e non solo usano parole che spesso fanno male, anche senza rendersene conto. Esprimere giudizi negativi sull’aspetto fisico non è una questione nuova, ma è diventata più evidente con la diffusione dei social media. Il dizionario Treccani 100 ha deciso di inserire tra i suoi lemmi quelli più comuni usati per offendere il corpo altrui, come balena o ciccione, senza accenti moralistici ma con rigore, spiegando il loro significato e, quando possibile, proponendo modi diversi di esprimersi.
Esempi di termini e alternative linguistiche
Ad esempio, il termine “balena” viene descritto come espressione usata in tono spregevole per definire una persona molto grassa. Simili parole, spesso sentite sin dall’infanzia, lasciano tracce nella percezione che una persona ha di sé. Del resto non sono solo termini legati al peso: ci sono parole rivolte ad altre caratteristiche, come “brufolosa/o”, “nasona”, “quattrocchi”, o “sgorbio”, tutte usate per deridere e marchiare l’altro. Il dizionario le segnala non per censurarle ma per spiegare il loro peso e invitare a riflettere sull’uso che si fa del linguaggio.
Leggi anche:
Oltre a indicare il significato e il contesto di questi termini, il dizionario suggerisce termini più oggettivi o neutri, come “sovrappeso” o “corpulento/a”, che hanno connotazioni cliniche o descrittive, escludendo il giudizio negativo. Proposte di questo tipo vogliono favorire un modo di parlare che rispetta l’altro senza rinunciare alla chiarezza. Ne sono esempi anche parole con sfumature positive come “formosa/o” o “longilineo/a”, che trasformano aspetti fisici potenzialmente oggetto di scherno in caratteristiche valorizzate.
La risposta istituzionale al fenomeno del body shaming in italia
Nel marzo 2025 la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una legge per istituire una giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico. Questa decisione arriva in risposta a un fenomeno diffuso tra i giovani: il body shaming si manifesta come una forma di bullismo verbale in crescita che provoca danni reali alla salute mentale.
La proposta di legge, ora all’esame del Senato, sottolinea come il linguaggio possa ferire e alimentare stereotipi pericolosi. La scelta di una giornata nazionale mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul problema, promuovendo iniziative educative e culturali mirate a prevenire ogni forma di discriminazione legata all’aspetto fisico. La legge introduce un momento dedicato alla riflessione sul tema e a diffondere un uso della parola più attento.
Questo intervento legislativo si accorda con progetti nelle scuole, dove insegnanti e operatori cercano di insegnare a riconoscere e respingere il body shaming. Si tratta di un percorso lungo, che richiede la collaborazione di famiglie, media e istituzioni. Per troppo tempo termini offensivi sono stati sdoganati come scherzi o ironie innocenti. Oggi la consapevolezza cresce rispetto al loro impatto e all’esigenza di una comunicazione che non derida, ma riconosca ogni persona con rispetto.
L’impatto del linguaggio sulla percezione di sé e sugli altri
Ogni parola porta con sé un peso e contribuisce a costruire o distruggere l’autostima. I termini usati per parlare del corpo possono segnare la vita di chi li riceve, soprattutto in momenti sensibili come l’adolescenza. Per questo il modo in cui si descrivono le caratteristiche fisiche deve andare oltre il semplice giudizio estetico, che spesso si basa su stereotipi.
Ecco perché la ricerca di alternative più neutrali o positive ha senso non solo in un dizionario, ma nella vita di tutti i giorni. Parole come “formosa” raccontano di sporgenze armoniose, “longilineo” invece di “troppo magro”, danno a chi ascolta un’immagine più accogliente e meno colpevolizzante. Questo linguaggio contribuisce a modificare l’atteggiamento collettivo, riducendo il rischio di ghettizzazione e isolamento.
Parlare del corpo senza sarcasmo o cattiveria stimola relazioni migliori e un clima sociale più civile. La distinzione tra ironia e derisione deve essere insegnata ma soprattutto capita e interiorizzata. Le parole non sono neutrali: agiscono sulla mente e sul cuore delle persone, influenzano la percezione che si ha di sé e degli altri e possono rafforzare il senso di appartenenza o, al contrario, alimentare la solitudine.
L’importanza di un uso consapevole della lingua nelle scuole e nei media
Il nuovo dizionario e la legge sulla giornata nazionale si inseriscono dentro un quadro più ampio di educazione alla comunicazione. Scuole e media hanno il compito di educare a un linguaggio più rispettoso che eviti termini offensivi e contrasti inutili. Negli istituti scolastici, insegnanti organizzano laboratori per spiegare quali parole usano e come possono essere percepite dai compagni.
Anche i media sono chiamati a una maggiore attenzione. Titoli, commenti e contenuti sui social devono rifuggire da definizioni che umiliano o ridicolizzano. Costruire una cultura del rispetto passa per controllare la scelta dei vocaboli proprio quando si parla di aspetto fisico. Non si tratta di censura, ma di responsabilità. La lingua può aiutare a contenere i danni del bullismo verbale e favorire un dialogo più sereno.
Famiglie e comunità devono affiancare questo percorso, spiegando ai giovani il valore dei termini e i limiti tra una descrizione e una derisione. È un lavoro complesso che richiede costanza. Le parole da sole non bastano ma sono un primo passo, se scelte con cura e usate con consapevolezza. Guardare con occhi nuovi il dizionario ci costringe a riflettere su come la lingua sia parte della vita quotidiana e sulle responsabilità di chi parla.
Sin dal vocabolario emerge che certe parole caricano sentimenti negativi che si potrebbero evitare. Orientare verso alternative più precise e rispettose significa indurre un cambiamento culturale necessario oggi che le immagini e i giudizi si moltiplicano senza controllo. La sfida resta aperta: usare la lingua non per dividere ma per dare spazio a ogni persona, dentro e fuori dallo schermo.