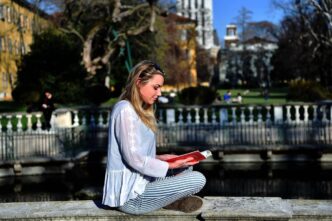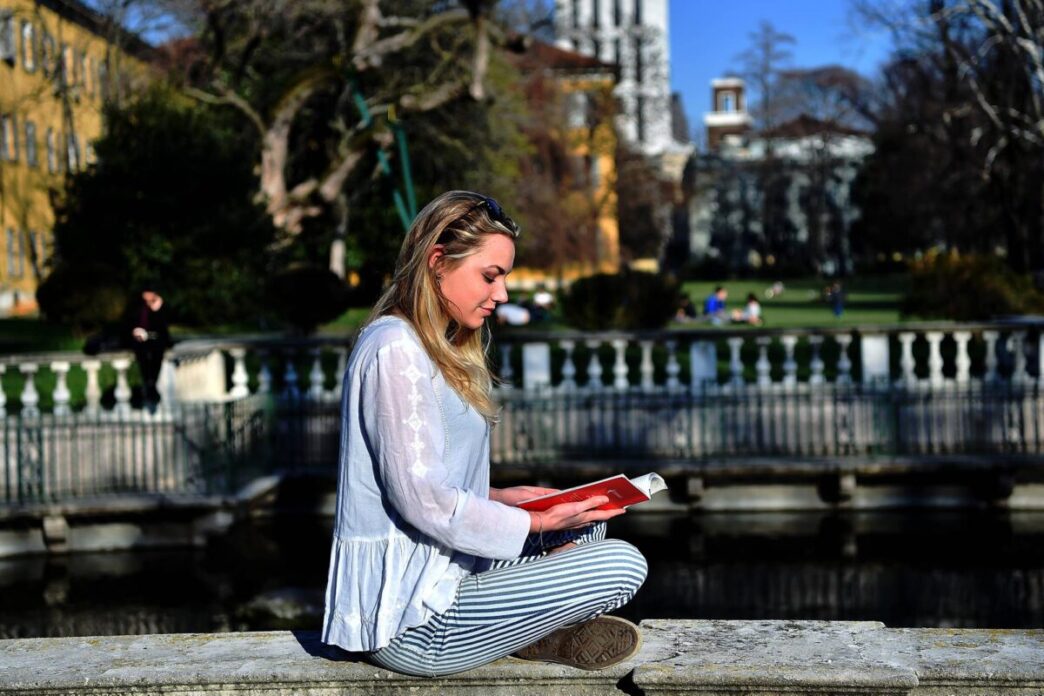Il lessico della poesia italiana, un patrimonio culturale affondato nelle opere di grandi autori come Dante, Petrarca e Leopardi, sta subendo un significativo ridimensionamento tra le nuove generazioni. Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, avverte che vocaboli storici come “lumi” e “mesto” stanno cadendo nell’oblio, risultando incomprensibili per i giovani. Nel contesto attuale, la riscoperta e la praticità del linguaggio poetico sembrano essere sempre più lontane dall’insegnamento scolastico tradizionale. Un tema che merita un’analisi approfondita.
Il deterioramento del lessico poetico
L’analisi di Paolo D’Achille pone l’accento sulla conservazione quasi invariata del lessico poetico dal tempo di Dante fino a Leopardi, un linguaggio che ha compiuto un viaggio semantico significativo. Oggi, quelle parole, una volta comuni nella poesia, sembrano estranee alla competenza linguistica dei giovani. La lettura di testi poetici del passato è diventata sporadica tra gli studenti, nonostante la sua importanza e necessità. D’Achille riporta un esempio calzante: una studentessa delle scuole medie, nell’interpretare un verso di un poeta, ha frainteso il significato di “filar”, confondendolo con “guardare”. Questo episodi evidenziano il problema sostanziale nel sistema educativo odierno, dove la letteratura storica è sottovalutata rispetto a testi contemporanei, portando a una carenza di familiarità con un linguaggio che informa opere liriche eseguite in tutto il mondo.
D’Achille sottolinea che ciò crea una disparità tra gli studenti nostrani e quelli di altri paesi che studiano la lingua italiana attraverso i testi d’opera, essenziali per comprendere appieno l’arte musicale ma anche le sottigliezze linguistiche necessarie per una corretta esecuzione. Questa perdita del lessico poetico rappresenta una minaccia per la ricchezza culturale, e il presidente della Crusca invita il sistema scolastico a ripensare l’approccio all’insegnamento della poesia.
Leggi anche:
La funzione innovativa dei poeti italiani
Oltre a mantenere viva la lingua tradizionale, i grandi poeti della storia italiana hanno anche dimostrato una sorprendente capacità di inventare nuovi termini, contribuendo così a un arricchimento lessicale. Dante, ad esempio, è noto per aver coniato una vasta gamma di parole, sottolineando l’importanza della creatività linguistica. D’Achille menziona il termine “odiosamato”, creato da Vittorio Alfieri, un esempio di unione tra opposti. Al tempo di D’Annunzio, la nascita di parole come “scudetto”, “velivolo” e nomi propri come “Ornella” ha influenzato il vocabolario comune. Tuttavia, come remarca D’Achille, queste influenze sono state sempre più rare nel linguaggio poetico moderno, che ha visto una transizione verso una forma più pragmatica e “funzionale”, spogliata di elementi estetici.
Questa evoluzione del linguaggio poetico mostra come la poesia, un tempo processo fondamentale per la lingua italiana, ha subito un ridimensionamento, riducendo così il suo ruolo esclusivo di modello linguistico. Pasolini lo aveva previsto, anticipando una spinta verso un’italiano più semplice e diretto, più che poetico.
L’importanza di una formazione poetica
In merito alla creazione poetica contemporanea, D’Achille sostiene che, sebbene i giovani continuino a scrivere, spesso non seguono i modelli della tradizione. Senza un riferimento adeguato ai poeti del passato, rischiano di produrre opere insipide e naif, privi della profondità e della struttura che caratterizzano la grande poesia. D’Achille afferma che per migliorare la loro scrittura, i poeti emergenti dovrebbero immergersi nei testi poetici, comprendendo le forme e i contenuti che hanno reso la poesia italiana un faro della cultura mondiale.
Oggi, le letture tendono verso autori contemporanei o traduzioni, e troppi giovani si allontanano dai grandi poeti, senza apprezzare le ricchezze linguistiche che possono ispirare una nuova generazione di poetesse e poeti, cominciando proprio da Dante. Le tematiche universali trattate dal sommo poeta possono trovare risonanza anche nelle esperienze contemporanee, e una lettura attenta di tali testi permetterebbe di recuperare un patrimonio perduto.
Evoluzione del lessico italiano e neologismi
Oltre alla questione del lessico poetico, D’Achille evidenzia come il patrimonio linguistico italiano stia subendo sia un’espansione che un restringimento. Sebbene i giovani usino un numero maggiore di parole rispetto al passato, vi è anche una grossa parte di vocaboli in declino, spesso legati a oggetti ormai desueti. L’apporto della tecnologia ha trasformato il linguaggio usato quotidianamente, con la scomparsa di termini legati a oggetti obsoleti, come “mangianastri” o “giradischi”.
I neologismi, se pur importanti, tendono a emergere più nelle conversazioni quotidiane che in un contesto letterario. I due principali filoni di neologismi comprendono quelli che derivano da prefissi e suffissi e quelli semantici, che ridisegnano significati noti. Tuttavia, gran parte di queste nuove parole riguarda ambiti specialistici e giovanili, mentre termini di uso quotidiano come “camicia” continuano a mantenere la propria rilevanza, nonostante le nuove influenze. Questo evidenzia come il linguaggio sia in continua evoluzione, rispecchiando i cambiamenti culturali e sociali che lo accompagnano.
La riflessione su questi temi è fondamentale per garantire una continuità linguistica che sappia abbracciare il passato e guardare al futuro.